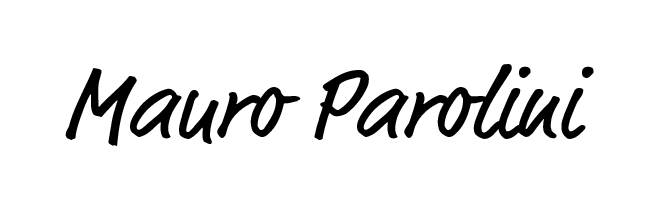Tuttavia, proprio oggi, «poiché grande è il disordine sotto il cielo spiega Paolucci a Tempi la situazione è eccellente per agire». La strada da seguire è chiara, spiega il professore, «è quella indicata nel recente incontro con gli artisti da Benedetto XVI, la via pulchritudinis», e richiamata ancor prima dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Paolo VI, «il Papa che, meglio di ogni altro, è stato consapevole di questa apparente incolmabile frattura e che tuttavia seppe richiamare gli artisti alla loro vera missione, quella che, per usare ancora le parole di Benedetto XVI, si esplicita nel compito di essere custodi della bellezza».
Bellezza, è questo il centro gravitazionale cui attorno tutto ruota. Nel suo discorso, Benedetto XVI lha richiamata più volte, ricordando che Hans Urs von Balthasar aprì la sua Gloria. Unestetica teologica con la frase «la nostra parola iniziale si chiama bellezza», che Fedor Dostoevskij ritenesse che lumanità potesse vivere senza scienza e pane, «ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere», perché ha detto Ratzinger è lei che «richiama luomo al suo destino ultimo, lo rimette in marcia, lo riempie di nuova speranza, gli dona il coraggio di vivere fino in fondo il dono unico dellesistenza». «La bellezza chiosa Paolucci è necessaria alla condizione umana. La Chiesa cattolica lo ha sempre richiamato e su questa convinzione ha saputo giocare spregiudicati azzardi. Fra i mille esempi che si potrebbero elencare e di cui questo museo diffuso che è lItalia è testimonianza viva, citerò solo quello che accadde a Roma nel 1508. Papa Giulio II vi chiamò due giovani artisti per dipingere la Cappella Sistina e la Stanza delle Segnature. Michelangelo aveva 32 anni, Raffaello 25 anni. La Chiesa è sempre stata amica dellarte e degli artisti, fidandosi della loro libertà espressiva: si pensi solo alla Morte della Vergine di Caravaggio, o al fatto che il cristianesimo, figlio dellebraismo, la più feroce religione aniconica dallantichità, ha saputo seguire unaltra strada, quella del vero visibile, evitando anche la riduzione a ieroscrittura dellislam che tutto condensa nella cifra e nel segno». La religione della carne, del logos fatto uomo, «è allorigine dellarte occidentale. Senza quella che io chiamo la bulimia del cristianesimo, il suo vorace desiderio di imparare, valorizzare, riutilizzare tutto, oggi non avremmo le nuvole di Giovanni Bellini, i riflessi nello specchio di Jan Van Eyck, la Canestra di frutta di Caravaggio, la Zattera di Medusa di Géricault».
Oggi, invece. «Oggi viviamo in unepoca di blackout, in cui persino limmagine del crocifisso è considerata sconveniente. Tutto è depurato, decurtato, liofilizzato. La bellezza è ridotta a eccitazione sessuale oppure a consolazione effimera. Gli uomini non sanno più cosa e a chi chiedere. Ci siamo abituati a unidea di bellezza come bene di consumo, figlia di unidea di uomo che è tautologica: io sono quel che sono, e basta». Lo si può appurare anche sul versante artistico, con opere che sono figlie della paura e della vergogna di affrontare grandi e millenari interrogativi che sappiano andare al di là della contingenza. «A volte, è come rintracciabile una sorta di imbarazzo negli artisti e lo constatiamo nellosservare questarte moderna disarticolata e ripetitiva, ridotta a spettacolo e scandalo. Oggi, persino un Morandi o un Buzzi faticherebbero a imporsi».
Lorigine dellallontanamento tra arte e fede, spiega Paolucci, ha inizio nellOttocento, «quando il pensiero prende altre strade e purtroppo anche la Chiesa si chiude in difesa, attestandosi su stili tradizionali come cercando una consolatoria rassicurazione di fronte a quei movimenti che mettevano il mondo a soqquadro». Così sè consumato il divorzio e larte cristiana ha scelto «di disertare il mondo della contemporaneità artistica, inabissandosi come un fiume carsico. Oppure è il fenomeno di cui tutti ai nostri giorni siamo testimoni aprendosi alle forme di un caotico eclettismo che cerca di tenere insieme astrazione e figura, novità e tradizione, liturgia e funzione, segno e messaggio».
Lincarnazione del possibile
Il compito è oggi quello indicato da Benedetto XVI agli artisti: tornare a custodire la bellezza. «Ricucire lo strappo prosegue Paolucci è impresa ardua, ma non impossibile, come comprese con acutezza già Paolo VI che volle che proprio qui, nei Musei vaticani, fosse aperto un luogo per larte moderna in cui trovassero spazio artisti come Bacon, Morandi, Buzzi. Quello è stato un primo aggancio con la modernità per superare la frattura». Perché, poi, se si ripercorrono le parole di Benedetto XVI si constata che non vè spazio per la ritirata dal mondo, che nulla ripiega verso le blandizie di unarte tranquilla e omertosa dellumano dramma. Anzi. Benedetto XVI ha richiamato le parole del pittore Georges Braque secondo cui «larte è fatta per turbare», e anche Paolucci richiama «quel che è il vero scopo dellarte: rendere testimonianza della religiosità che è insita in ogni grande spirito: lo stupore per il creato, gli affetti, i supremi interrogativi di fronte alla nascita e alla morte, le contraddizioni, le sofferenze. Non importa che lartista non sia credente o persino ateo, egli fa arte religiosa se sa introdurci in questa realtà. è un aspetto su cui cè molto da imparare, anche in ambito cattolico, affinché il cristianesimo non si riduca a nostalgia o folclore». Che gli artisti tornino al bello, perché, come diceva Simone Weil «il bello è la prova sperimentabile che lincarnazione è possibile».